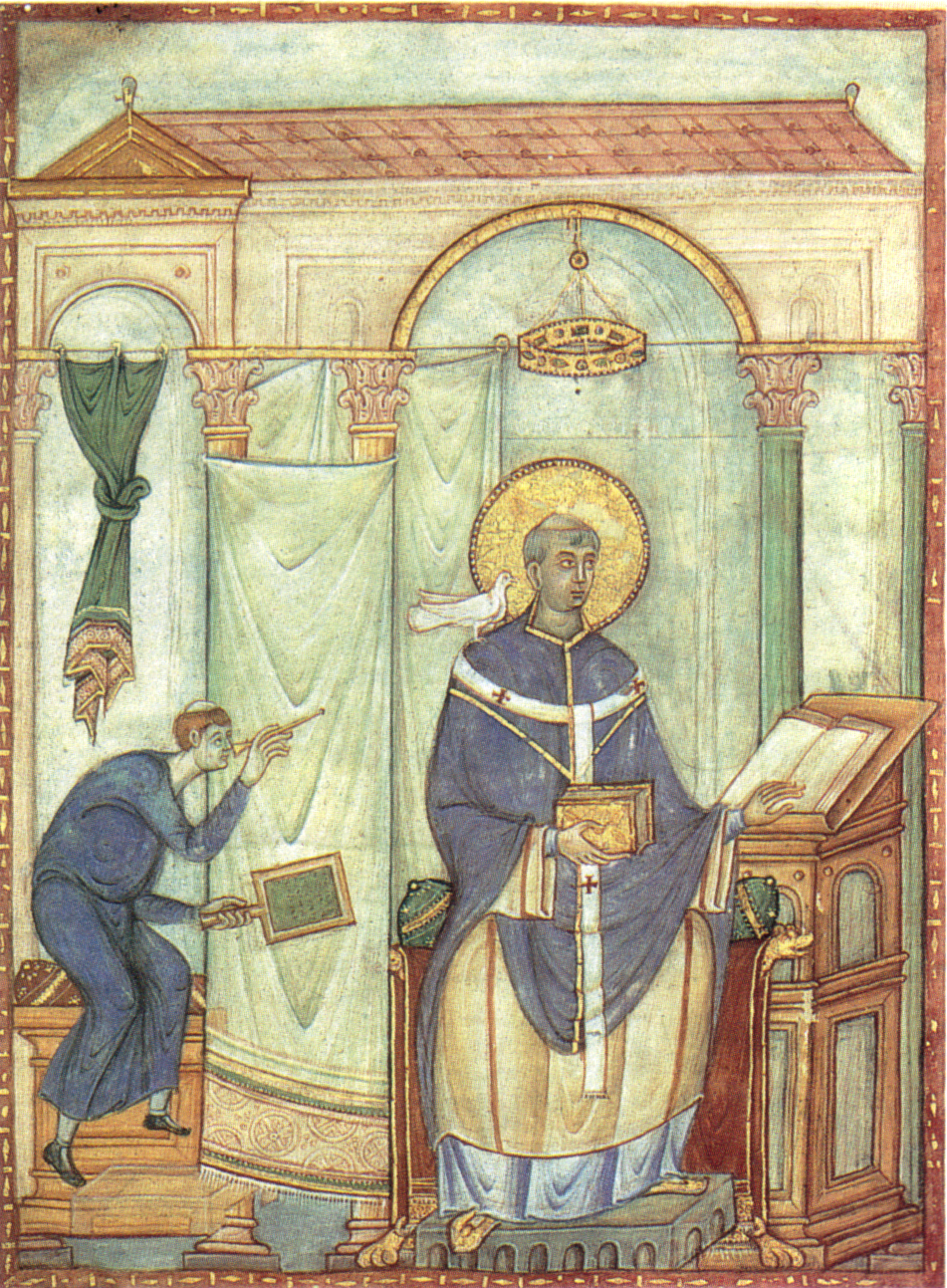a cura di Paolo Bottini
* * *
«Ognuno chiede in qual modo cantare a Dio. Canta a Lui, ma canta bene. Egli non vuole che le sue orecchie siano offese. Canta bene, fratello.» (S. Agostino, Esposizioni sui salmi, Commento secondo al salmo 32, paragrafo 8)
Liturgia & Musica
Questo spazio nasce dalla mia esperienza di moderatore della mail circolare "Liturgia&Musica", avviata nel dic. 2005 per conto della “Associazione Italiana Organisti di Chiesa” (di cui fui segretario dal 1998 al 2011) al fine di tener vivo il dibattito intorno alla Liturgia «culmine e fonte della vita cristiana» e al canto sacro che di essa è «parte necessaria ed integrante» unitamente alla musica strumentale, con particolare riferimento alla primaria importanza dell'organo.
______________
sabato 14 febbraio 2015
«L’organista si obbliga ad...» - Per un ripristino della figura dell’«organista titolare» in Italia
sabato 31 gennaio 2015
Gradi di solennità del canto liturgico
Estratto dalla istruzione Musica Sacram:
III. Il canto nella celebrazione della messa
27. Nella celebrazione dell’Eucaristia, con la partecipazione del popolo, specialmente nelle domeniche e nei giorni festivi, si preferisca, per quanto è possibile, la forma della Messa in canto anche più volte nello stesso giorno.
28. Rimane in vigore la distinzione tra Messa solenne, Messa cantata e Messa letta, stabilita dalla Istruzione del 1958 (n. 3), secondo la tradizione e le vigenti leggi liturgiche. Tuttavia, per motivi pastorali, vengono proposti per la Messa cantata dei gradi di partecipazione, in modo che risulti più facile, secondo le possibilità di ogni assemblea liturgica, rendere più solenne con il canto la celebrazione della Messa. L’uso di questi gradi sarà così regolato: il primo potrà essere usato anche da solo; il secondo e il terzo, integralmente o parzialmente, solo insieme al primo. Perciò si curi di condurre sempre i fedeli alla partecipazione piena al canto.
29. Il primo grado comprende:
a) nei riti d’ingresso:
— il saluto del sacerdote celebrante con la risposta dei fedeli;
— l’orazione;
b) nella liturgia della parola:
— le acclamazioni al Vangelo;
c) nella liturgia eucaristica:
— l’orazione sulle offerte;
— il prefazio, con il dialogo e il Sanctus;
— la dossologia finale del Canone;
— il Pater noster con la precedente ammonizione e l’embolismo:
— il Pax Domini;
— l’orazione dopo la comunione;
— le formule di congedo.
30. Il secondo grado comprende:
a) il Kyrie, il Gloria e l’Agnus Dei;
b) il Credo;
c) l’orazione dei fedeli.
31. Il terzo grado comprende:
a) i canti processionali d’ingresso e di comunione;
b) il canto interlezionale dopo la lettura o l’epistola;
c) l’Alleluia prima del vangelo;
d) il canto dell’offertorio;
e) le letture della sacra Scrittura, a meno che non si reputi più opportuno proclamarle senza canto.
32. L’uso legittimamente vigente in alcuni luoghi, qua e là confermato con indulto, di sostituire con altri testi i canti d’ingresso, d’offertorio e di comunione che si trovano nel Graduale, può essere conservato, a giudizio della competente autorità territoriale, purché tali canti convengano con il particolare momento della Messa, con la festa e il tempo liturgico. La stessa autorità territoriale deve approvare il testo di questi canti.
33. È bene che l’assemblea partecipi, per quanto è possibile, ai canti del «Proprio»; specialmente con ritornelli facili o forme musicali convenienti.
Fra i canti del «Proprio» riveste particolare importanza il canto interlezionale in forma di graduale o di salmo responsoriale. Esso, per sua natura, fa parte della liturgia della parola; si deve perciò eseguire mentre tutti stanno seduti e in ascolto e anzi, per quanto è possibile, con la partecipazione dell’assemblea.
34. I canti che costituiscono l’Ordinario della Messa, se sono cantati su composizioni musicali a più voci, possono essere eseguiti dalla «schola» nel modo tradizionale, cioè o « a cappella» o con accompagnamento, purché, tuttavia, il popolo non sia totalmente escluso dalla partecipazione al canto.
Negli altri casi, i canti dell’Ordinario della Messa possono essere distribuiti tra la «schola» e il popolo, o anche tra due cori del popolo stesso, in modo cioè che la divisione sia fatta a versetti alternati, o in altro modo più conveniente, che tenga conto di sezioni più ampie del testo.
In questi casi, tuttavia, si tenga presente:
— Il Credo, essendo la formula di professione di fede, è preferibile che venga cantato da tutti, o in un modo che permetta una adeguata partecipazione dei fedeli.
— Il Sanctus, quale acclamazione finale del prefazio, è preferibile che sia cantato, ordinariamente da tutta l’assemblea, insieme al sacerdote.
— L’Agnus Dei può essere ripetuto quante volte è necessario, specialmente nella celebrazione, durante la frazione del Pane. E bene che il popolo partecipi a questo canto, almeno con l’invocazione finale.
35. È conveniente che il Pater noster sia cantato dal popolo insieme al sacerdote [22]. Se è cantato in latino, si usino le melodie approvate già esistenti; se si canta in lingua volgare, le melodie devono essere approvate dalla competente autorità territoriale.
36. Nulla impedisce che nelle Messe lette si canti qualche parte del «Proprio» o dell’« Ordinario». Anzi talvolta si possono usare anche altri canti all’inizio, all’offertorio, alla comunione e alla fine della Messa: non è però sufficiente che siano canti «eucaristici», ma devono convenire con quel particolare momento della Messa, con la festa o con il tempo liturgico.
mercoledì 24 dicembre 2014
«La codificazione ufficiale della mediocrità» secondo Oscar Mischiati
tutti hanno conosciuto Oscar Mischiati come un personaggio - diciamo così - di non facile approccio... ma quel che è certo, egli era un sapiente e una persona di buon senso: lo dimostra lo scritto che Vi consegno qui in calce (dettato ormai quasi trent’anni fa), il quale credo sia gradito alla maggior parte di Voi, in quanto non molto noto.
Paolo Bottini
Intervento di OSCAR MISCHIATI nel convegno di studi
"I beni culturali ecclesiastici tra culto e tutela"
Promosso dalla Amministrazione Provinciale di Varese con la collaborazione di:
Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Lombardia
Commissione per la Tutela degli Organi Artistici
Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici della Lombardia
Sabato 24 gennaio 1987
Il patrimonio organario antico italiano è ricchissimo, non solo per la quantità, ma anche per la qualità e varietà.
È difficile, allo stato attuale delle conoscenze, fornire dati precisi sulla consistenza, considerata anche l’estrema disuguaglianza nella distribuzione territoriale: ad esempio una provincia come quella di Belluno presenta soltanto un’ottantina di strumenti con interesse storico-artistico, la sola città di Bologna ne possiede oltre un centinaio. D’altro canto, se alcuni tipi d’organo (quello veneziano settecentesco, quello lombardo ottocentesco) presentano caratteri abbastanza diffusi e comuni (ciascuno nel proprio genere, ben inteso), profonde diversità qualificano e segnano gli strumenti attraverso i tempi e i luoghi: un organo rinascimentale toscano non è la stessa cosa di un coevo strumento lombardo. E gli esempi potrebbero continuare.
La maggior parte di tale patrimonio versa in condizioni precarie di sopravvivenza, vuoi per prolungati periodi di abbandono (segnati dai danni prodotti dal tarlo, dai topi, talvolta dallo stillicidio dell’acqua piovana), vuoi per azioni vandaliche di asportazione e danneggiamento del materiale (tipico il caso di canne divelte e calpestate), vuoi infine per interventi inconsulti di manomissione: perlopiù volti ad adattare gli strumenti alle limitate cognizioni musicali e al cattivo gusto di organisti dilettanti, sprovveduti o velleitari; s’intende alludere alla sostituzione di tastiere e pedaliere ’più comode’ rispetto alla presunta scomodità di quelle originali, così come all’eliminazione di autentiche sonorità organistiche (Flauto in XII, Cornetto, registri ad ancia, file acute di Ripieno) perché ’stridule’ e alla loro sostituzione con materiale scadente (zinco) confezionato in maniera industriale e finalizzato ad effetti sdolcinati e d’infimo gusto, estranei all’arte e alla cultura musicale, meno che mai convenienti ai livelli di qualità e di dignità del tempio e del rito.
Eppure queste operazioni per lunghi (troppo lunghi!) decenni sono state qualificate come "riforma liturgica" laddove è da stigmatizzare un atteggiamento tuttora perdurante: quello di assumere come metro di valutazione degli organi (e non solo quelli) una categoria storicamente e culturalmente inconsistente quale quella di "liturgico" (ciò che era liturgicamente tassativo per Pio XII non lo è stato più con Paolo VI; né la situazione ha finora cessato di essere fluida; ma qui basti rilevare la relatività del termine).
Con il decadere dell’esercizio della musica in chiesa da livelli di qualità non di rado prestigiosa (di necessità, storicamente concreta e individuata: di volta in volta il gregoriano nel periodo romanico, la primitiva polifonia nel gotico, la grande arte contrappuntistico-imitativa nel Rinascimento e nel Barocco, lo stile "concertato" nel Barocco fino a ben addentro l’Ottocento) a livelli non professionali si accompagnò un singolare fenomeno: la codificazione ufficiale della mediocrità.
Ma non meno assurde e ridicole sono le pretese "liturgiche" attuali di volere l’organo o l’organista in mezzo all’assemblea, confondendo pateticamente le esigenze del canto assembleare con le leggi dell’acustica e con le esigenze di un serio esercizio dell’arte dei suoni.
In ossequio a tale confuso velleitarismo si vorrebbero comandati gli organi a distanza mediante trasmissione elettrica, di fatto contraddicendo all’esigenza primaria della fonte sonora prossima a chi canta e suona e indulgendo ad un tipo squalificato di organo ripudiato universalmente dalla cultura organistica e musicale.
Senza contare che la riforma protestante e calvinista sono riuscite a far cantare le assemblee dei fedeli senza rimuovere o manomettere gli organi; più semplicemente e correttamente si è inculcata l’educazione musicale di base generalizzata, si è allestito un repertorio musicale qualificato ed appropriato di canti e si è affidato l’organo ad un professionista. Tutte cose che non si ottengono dall’oggi al domani, come "italianamente" si è preteso di fare in maniera confusa e pasticciona.
E come un tempo le commissioni diocesane di musica sacra inculcavano e benedicevano le riforme liturgiche degli organi - di fatto perseguendo un assurdo appiattimento e livellamento in netto contrasto con una tradizione senza pari per varietà e fantasia creativa, senza contare l’avallo perennemente concesso agli operatori più squalificati del settore (cui rifiutiamo per ragioni oggettive la qualifica di "organari") - così oggi da quegli stessi ambienti diocesani si ribadiscono posizioni in netto contrasto con gli indirizzi più aggiornati in campo organistico, organario, organologico e di tutela del patrimonio strumentale antico.
È stata quindi condizione storica strettamente necessitante per quanti nel nostro Paese hanno a cuore senza riserve la tutela e l’integrità del patrimonio storico organario richiamare l’attenzione degli uffici statali preposti a quelli che oggi complessivamente si usa chiamare "beni culturali" perché in questi ultimi fossero a pieno titolo compresi gli organi e gli strumenti musicali.
La situazione è lungi dall’aver trovato soddisfacente soluzione, anche perché nel nostro Paese, per una singolare distorsione di vecchia data, la tutela - e di conseguenza la preparazione dei funzionari ad essa preposti - è sempre stata ed è tuttora finalizzata ai fatti "visivi" (senza contare i condizionamenti delle valutazioni "estetiche"), disprezzando gli aspetti essenzialmente "storici", materiali e documentari dei manufatti e delle testimonianze in genere del passato: più volte, infatti, è accaduto che la "tutela" degli organi antichi giungesse a salvaguardare il solo prospetto, come se le canne interne e tutto il resto (tastiere, complesso dei comandi e dei meccanismi, somieri ecc.) non fossero anch’essi "oggetto" di rilevanza storica ed artistica ad un tempo. Quando addirittura non è accaduto che per mal inteso purismo architettonico organo e cantoria sono stati spazzati via come elemento ingombrante e "deturpante" (così nella Cattedrale di Pistoia o alla Madonna del Calcinaio a Cortona).
Un allargamento del campo visuale è quindi urgente e necessario, non solo in ottemperanza al dettato costituzionale, ma anche per adeguare l’opera della pubblica amministrazione agli orientamenti culturalmente più avvertiti e prevalenti da tempo nei paesi civili.
Ma l’intervento pubblico in materia organaria si giustifica anche per altri motivi.
Quando si parla di "chiesa", normalmente si identifica ’sic et simpliciter’ con la gerarchia; occorrerebbe ricordare che, più correttamente. Chiesa è la comunità di fedeli e di clero. A quest’ultimo spettano incontestabilmente i compiti magisteriale e sacramentale per la salvezza delle anime. Il "temporale" è invece incombenza dei fedeli costituiti, come cittadini, in legittime pubbliche aggregazioni, in una parola lo Stato, nella fattispecie la repubblica; della quale sono pure cittadini - con parità di doveri oltre che di diritti - i membri del clero e della gerarchia.
Sembra invece che a più di cent’anni di distanza questi ultimi non abbiano ancora accettato di buon animo la fine dello Stato pontificio e si considerino - e di fatto molto spesso si comportano - come se lo Stato non esistesse o addirittura come se l’intervento statale nel merito specifico della tutela storico-artistica (e quindi anche organaria) fosse un’illecita intrusione, una prevaricazione laicista nei fatti di culto e di religione.
Di qui la tendenza degli ecclesiastici in genere a sottrarre al "civile" quanto più è possibile e a gestirlo quale patrimonio esclusivo: in particolare, appunto, i beni culturali cosiddetti ecclesiastici, a cominciare dagli archivi; che sono innumerevoli, spesso imponenti, ma raramente gestiti correttamente e accessibili o fruibili in condizioni soddisfacenti per lo studioso.
Se è vero che il clero (anche per l’assottigliamento dei ranghi in conseguenza sia della flessione delle vocazioni, sia delle innumerevoli riduzioni allo stato laicale determinate dagli smarrimenti pre- e post-conciliari) è letteralmente travolto dalle incombenze pastorali, non si vede perché tali patrimoni archivistici non vengano depositati presso quelle strutture pubbliche create - nell’interesse di ’tutti’ - per la conservazione e la consultazione del materiale documentario che vi è conservato.
Ulteriore, elementare, ma - a quanto sembra - non altrettanto ovvia osservazione è che i beni culturali cosiddetti ecclesiastici sono proprietà non del clero, ma della chiesa, quindi anche dei fedeli. Non esistendo nell’ambito di quest’ultima forme e strutture amministrative o rappresentative dei fedeli stessi per una gestione culturalmente avvertita e comunitarimente trasparente di tale patrimonio (come lo erano le "opere" o le "fabbricerie", esistite con validità civile, giurica dal Medioevo al concordato del 1929), non si vede come tale compito non possa e non debba essere esercitato da quegli istituti pubblici, statali, esistenti in quanto prefigurati e regolati da leggi che i cittadini medesimi si sono date. È anzi sorprendente come il clero non riesca ancora oggi a concepire il pubblico ufficio come una struttura ’anche al suo servizio.
Certo, è storicamente più che giustificata la diffidenza, l’estraneità o l’insoddisfazione del cittadino nei confronti di questo Stato italiano e delle sue strutture, per lo più arcaiche, fatiscenti, inefficienti, lente, paralizzanti, onerose, insufficienti. Ma non è men vero che questo deplorevole stato di cose è anche storicamente frutto di plurisecolari prevaricazioni clericalesche e, in tempi a noi più prossimi, del valoroso contributo di "cattolici", politicamente o meno impegnati.
Altra materia di considerazioni è quella in ordine alla storia della cultura.
È infatti fuori di dubbio che al tutela rigorosa e il restauro storico-filologico sono caratteristica dei nostri tempi nel rapporto con i manufatti storico-artistici del passato; ed è altrettanto certo che il concerto e la prassi del restauro mutano nel tempi: si affinano i procedimenti, si arricchiscono le conoscenze e le esperienze, si moltiplicano le occasioni di verifica e di confronto, , si allarga il campo dell’attenzione; fino ad una dozzina d’anni addietro, ad esempio, non si prestava attenzione al recupero del "temperamento" antico nell’accordatura degli organi; ed è di questi ultimissimi tempi l’adozione della camera a gas anche in campo organario quale mezzo di disinfestazione dal tarlo delle parti lignee.
Tutte materie, come ognun vede, oggetto e fonte di studio, di ricerche, di dibattiti, di pubblicazioni; tutte cose cui certo il clero non è istituzionalmente tenuto né attrezzato.
Ma in ordine a quella stessa storia della cultura sarà lecito discutere e avanzare riserve in merito a scelte storicamente determinate della gerarchia: l’immagine, ad esempio, di una chiesa (come edificio), sobria, povera di immagini e di decorazioni non è - come si pretende da qualcuno - una reazione al tardo romanticismo, ma è piuttosto figlia proprio di quel romanticismo soggettivista che ha scarnificato la fede riducendola a "sentimento" e a fatto privato di coscienza, negando di fatto il concetto stesso di "religione" come rapporto oggettivo con il trascendente e demotivandone di conseguenza le manifestazioni esteriori.
Altrettanto discutibile che il rito si debba ridurre ad un fatto prevalentemente verbale, ossessivamente amplificato da microfoni e altoparlanti, impoverito di segni e di immagini, di valori estetici e simbolici, musicali, gestuali ecc., in un curioso, imprevedibile revival illuministico, in contrasto con tutta una ben radicata tradizione della nostra cultura, cui in definitiva si riconnettono da un lato la forma dialogica della filosofia platonica e dall’altro la struttura narrativa per parabole del testo evangelico.
Forse non era mai accaduto che la chiesa dovesse misurarsi con il giudizio in sede di storia della cultura, per secoli essendo stata essa stessa matrice di cultura; ma da quando ha cessato di svolgere questa funzione è andata anche scemando la sua credibilità (per usare un termine oggi di moda), essendo venuto meno l’oggettivo metro di valutazione del proprio ’modus operandi’ in seno all’umano consorzio.
La confezione di modelli sentimentali evasivi o fittizi o perlomeno di puro riferimento interno all’istituzione stessa - "exempli gratia" il liturgico (o la trilogia, ormai classico, di "bibbia, liturgia e terzo mondo") - non è certo idonea e sufficiente a reggere l’impatto con la cultura spesso ostile del mondo moderno; di qui il patetico smarrimento, l’acritico assorbimento o il disinvolto opportunismo di tanta parte del clero e del cosiddetto "mondo" cattolico.
In simile contesto non è certo tollerabile che gli organi antichi continuino ad essere vittima di mutevoli umori liturgici, quando per lunghi secoli essi hanno egregiamente svolto le loro funzioni; che poi l’attuale mutevolezza sia il segno di una chiesa - come qualcuno suppone - "più pura, più santa e più evangelica" di quella anteriore al Concilio Vaticano II è soltanto indice di confusione associata ad una presunzione d’orgoglio luciferino, purtroppo priva di concreti riscontri oggettivi.
sabato 29 novembre 2014
Il canto del salmo responsoriale
sabato 22 novembre 2014
Cecilia cederebbe il posto a Giovanni Battista ?!
Il culto popolare e religioso di Santa Cecilia è ispirato alla vita della giovane vergine Cecilia, martire cristiana a Roma all’inizio del III secolo d.C..
sabato 18 ottobre 2014
l'Otto-per-mille agli organisti ?!
Nulla è stato fatto (nemmeno detto) per gli organisti nel recente convegno di musica sacra promosso dall’Ufficio Liturgico Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana a Salerno [*] !
Sarebbe stato sufficiente prendere in carico la discussione circa la possibilità di attuare quanto saggiamente proponeva - ormai nel lontano 1999 - don Marino Tozzi, responsabile della Commissione di Musica Sacra della diocesi di Forlì-Bertinoro, di cui sotto riporto dettaglio!
La ripresa di un eventuale dialogo tra musicisti di chiesa e CEI dipende unicamente dal rinnovato sodalizio professionale dei primi!…
Meditate, gente…
Paolo Bottini
Cremona, 18 ottobre 2014
[*] cronaca del convegno (con possibilità di scaricare quasi tutte le relazioni)
* * *
Una proposta di don Marino Tozzi, da La musica sacra e l’otto per mille, in «Bollettino Ceciliano» 1999/4, pp. 111-112:
Un contributo-incentivo della CEI dai fondi dell’8 per mille alle chiese cattedrali (o altre chiese scelte dal vescovo) prive di maestro di cappella (e/o organista) regolarmente stipendiato se decidono di assumerlo con queste condizioni:
- un regolare concorso per titoli o esami che comprovi l’effettiva preparazione musicale e liturgica;
- impegno di chi viene assunto a costituire una Schola cantorum e ad assicurare il servizio secondo un clendario annuale prestabilito;
- un compenso ipotetico di un milione di vecchie lire [§] al mese, quale stipendio-base: da completare da parte dell’ente ecclesiastico interessato attraverso integrazioni, emolumenti per celebrazioni, alloggio gratuito. [...]
Nell’attuale panorama di squallore e nel clima di disarmo in cui versa la musica nella scuola, nelle istituzioni, nei mezzi di comunicazione, di fronte al "grido di dolore" che sale da tanti giovani specialmente organisti che hanno compiuto studi seri e che vorrebbero impegnarsi con passione, professionalità e senso di fede, sarebbe questo un forte segnale da parte della Chiesa italiana di impegno nel settore della musica sacra [...] e un’indicazione precisa che il "progetto culturale" della Chiesa italiana sta scendendo dai principi ai fatti concreti.
[§] mutatis mutandis: euro 700,00 circa (Ndr).
giovedì 4 settembre 2014
No latino? No gregoriano!
Colgo l'occasione per inoltrare, qui in calce, il recente scritto di Giacomo Baroffio intitolato "il futuro del canto gregoriano".
Circa questo argomento, il busillis, a mio parere, sta in due difficoltà oggettive attualmente insormontabili, le quali determinano di fatto l'esclusione del canto gregoriano dal culto divino della chiesa cattolica:
1) il famigerato «ceteris paribus» di SC 113 [*] che in italiano suona (ambiguamente): «La Chiesa riconosce il canto gregoriano come canto proprio della liturgia romana; perciò nelle azioni liturgiche, a parità di condizioni [ceteris paribus], gli si riservi il posto principale»: cosa voglia dire quel "a parità di condizioni", piazzato lì quasi a compromesso dopo le acerrime discussioni dei padri conciliari durante l'assise, è ancora oggi oggetto di dibattito...
2) è ben noto che la maggior parte degli uomini di chiesa oggi aborre l'utilizzo della lingua latina nel culto (prefendo, piuttosto, disturbare il clima di preghiera e raccoglimento con inutili e noiose didascalie che non fanno che interrompere il naturale svolgimento del rito), nonostante il desiderio di SC 36 che «L'uso della lingua latina, salvo diritti particolari, sia conservato nei riti latini».
Come tutti sanno, il latino nel culto divino della chiesa cattolica è stato ben presto frettolosamente accantonato, assieme al canto gregoriano, nei primissimi anni del dopoconcilio [+], grazie anche alla spinta ultra-progressista del movimento "Universa Laus".
Si pensi solo al repertorio dei monaci camaldolesi: subito dopo l'ultimo concilio ecumenico si diedero da fare senza troppe remore a ripensare in italiano tutto il loro repertorio [§], accantonando completamente il gregoriano storico! Questo è solo l'esempio più virtuoso (ho cantato personalmente le antifone e i salmi di Camaldoli e assicuro che è un esperimento molto ben riuscito), invece nella maggior parte delle parrocchie italiane si continua a tutt'oggi a cantare stancamente un repertorio raffazzonato alla meno peggio, perché tutto sommato - diciamocelo - la liturgia è la cosa cui si dà meno importanza della vita cristiana in parrocchia!
Di conseguenza, come è ovvio: no latino? no gregoriano!!
In buona sostanza, l'uso del canto gregoriano in ambito cultuale dipende solo ed esclusivamente dalla volontà dei vescovi e, non da meno, da quella dei parroci.
E con buona pace dei gregorianisti incalliti, ai quali non rimane che rifugiarsi in esibizioni concertistiche che sono la noia più mortale che ci possa essere!
Buona lettura e grazie per la cortese attenzione.
Paolo Bottini
Cremona, il 3 settembre 2014
[+] per approfondire leggasi questo articolo di Sandro Magister
* * *
IL FUTURO DEL CANTO GREGORIANO [#]
di Giacomo Baroffio [°]
La situazione del canto gregoriano in Italia oggi è molto confusa a causa di differenti motivi. Ricordo solo i principali:
1] lo scontro tra le proposizioni elogiative del magistero pontificio e l'atteggiamento concreto di gran parte del clero, talora indifferente, spesso contrario, in modo deciso e anche con rabbia iconoclasta; [1]
2] la conseguente diffusa incertezza circa la sua identità e la sua collocazione nella Chiesa e nella società: che cos'è questo canto, quale il suo valore, quale spazio può o deve occupare;
3] l'incertezza a livello interpretativo con la coesistenza di modalità assai diverse, spesso conseguenza di una mancata formazione musicale e liturgica adeguata. Ci sono gruppi che cantano soltanto perché il "gregoriano" è un canto "esotico", richiama attenzione, gode di una certa simpatia in alcuni ambienti giovanili ...
In questo panorama, piuttosto desolante, ci si chiede se c'è un futuro per il canto gregoriano. Sono fermamente convinto che ci sia, ma penso che occorra affrontare il problema in modo corretto, altrimenti non si potrà giungere a una soluzione soddisfacente.
Il presente precede sempre, ma non genera quasi mai il futuro. Il presente si può prolungare nel tempo, dare qualche segno di apparente vitalità ma, nell'arco di una generazione o di pochi decenni, sfocia in uno stato di stagnazione. [2] Certo, persistono strutture che sembrano solide, mentre in realtà sono inaridite e sono sorrette dalla rigidità di una disciplina esteriore e dalla forza d'inerzia dell'abitudine.
A sessant'anni da quando ho iniziato a occuparmi di canto liturgico, la situazione intorno al canto liturgico è migliorata assai sotto vari aspetti. Si pensi alle innumerevoli edizioni di musica in gran parte accessibili in rete, alla possibilità di leggere e ingrandire antichi manoscritti in splendide fotografie digitali, alla gioia di ascoltare innumerevoli esecuzioni attraverso radio, CD, DVD, Youtube e altri canali. Sono tante occasioni che permettono di confrontarsi con differenti e anche provocanti interpretazioni. È un arricchimento inimmaginabile a metà del secolo scorso, ma tutto ciò - nonostante il numero infinito di duplicazioni - non ha la forza di superare o sfondare la barriera dell'immobilismo di fondo che fa del presente una landa inaridita, congelata.
Affinché il presente si apra al futuro è necessario che si ritorni alle origini, alla forza propulsiva creatrice e fantasiosa, all'entusiasmo umile capace di reggere il confronto con i propri fallimenti e altri ostacoli. Per evitare che le case religiose si riducano a pensionati per tristi brontosauri e zitelle inacidite, è necessario ritornare alle sorgenti, a vivere l'impulso originario dei fondatori. Chiunque essi siano, Benedetto o Francesco o Teresa d'Avila. Nell'ambito del canto gregoriano è urgente fare un'analoga operazione di ressourcement, direbbero i francesi. Il futuro si crea andando alle sorgenti, non con un movimento retrospettivo, all'indietro, di stampo archeologico e narcisistico.[3] Ciò che conta è uno slancio in avanti, attingendo alla fonte originaria forza e suggestioni di rinnovamento, proposte di novità, dinamiche innovatrici.
Questa, ora delineata a grandi tratti, è però soltanto una tappa. Si raggiungono le origini nel passato e si rileggono con gli occhi del presente per scoprire le vie del futuro. Quello che siamo soliti chiamare "canto gregoriano, canto romano-franco, canto liturgico tradizionale ..." - sempre "canto" diciamo per convenzione e abitudine - canto non è. Il gregoriano nella sua radice profonda è la Parola di D-i-o che il cantore profeticamente annuncia alla Chiesa. È inoltre la stessa Parola che il cantore innalza a D-i-o quale preghiera della Chiesa. In seguito il canto aderisce anche alla parola con cui la Chiesa proclama i mirabilia Dei e invita i credenti a condividere la sua preghiera di lode e di supplica. È quanto accade, ad esempio, in tanti responsori e canti delle Ore.
Se non si parte da questa realtà vissuta, è inutile pensare al futuro del canto gregoriano. Usciranno tanti nuovi articoli e libri che scandaglieranno fatti storici, tecnici, estetici, paleografici ... senza futuro, finendo per impantanarsi in discussioni inutili, in risultati ripetitivi e alla fine deludenti. Si faranno anche tanti concerti davanti a platee affollate. Qui precipitiamo in una situazione che oscilla tra il ridicolo e il tragico. Pretendiamo di proporre una musica di oltre 1000 anni fa, senza neppure sapere come si cantasse allora. È un giardino grottesco di pietra con tanti monumenti di ipotesi. D'altra parte, in prospettiva storica, il canto gregoriano è simile a una zattera di ipotesi sballottata dalle onde di un oceano tempestoso d'ignoranza.
Dopo queste parole sembrerebbe che tutto sia perduto e inutile. Al contrario. È ora di svegliarsi dal sonno e cercare di raggiungere le fonti dell'acqua viva che alimenta il canto, nutre i cantori, rinnova la Chiesa. L'acqua viva è la Parola di D-i-o. Di fronte ad essa è d'obbligo assumere l'atteggiamento di curiosità / amore / attaccamento, che hanno i piccoli nei confronti della voce della mamma e del babbo. "Lectiones sanctas libenter audire" ricorda san Benedetto. Non è questione di imporsi una disciplina, di affrontare un lavoro impervio. Nessuno ci obbliga a leggere la Bibbia in ebraico, anche se non sarebbe male condividere almeno questo desiderio con Teresa di Lisieux. Ci chiamiamo e siamo figli di D-i-o. La nostra gioia nasce dall'ascolto della sua voce, del timbro sonoro che ci raggiunge attraverso la mediazione del canto.
Si tratta, tuttavia, pur sempre di un cammino didattico che esige una serie di impegni: trovare il tempo per leggere la Bibbia; avere la forza di spazzare via i pensieri, anche buoni e positivi, che intasano mente e cuore; disporre di uno spazio di silenzio dove far risuonare la Parola con tutte le sfumature che essa può suscitare.
Un'indicazione pratica. Se non siamo abituati a fare della Bibbia il nostro libro di preghiera, imitiamo le sorelle e i fratelli che in Germania ogni giorno dell'anno ruminano una Losung, una parola d'ordine che apre e dilata il cammino quotidiano. In Germania si trova un libretto con una frase biblica per ogni giorno. Noi cattolici nei Paesi latini potremmo utilizzare facilmente come parola d'ordine il ritornello del salmo responsoriale oppure il verso dell'alleluia o il testo di un'antifona (introito e comunione).
Quando raggiungeremo un minimo di familiarità con la Parola e avvertiremo la necessità di ruminarla quotidianamente, allora sentiremo anche il bisogno di rivestire la Parola con il suo manto regale: una melodia che rende la voce di D-i-o più penetrante, inconfondibile, una melodia che scopre con delicatezza i tesori della Parola e ce li porge. Così li possiamo gustare, li lasciamo scendere nel profondo di noi stessi affinché dall'intimo cambino la nostra vita. La Parola allora ci rende profeti e nel canto annunciamo la speranza nel futuro che D-i-o solo può aprire e costruire. Per il bene di ciascuno e di tutti, nella Chiesa e nella società civile.
Questo è il futuro del canto gregoriano. Questo è il futuro dei cantori che accolgono il dono della profezia e - nella forza dello Spirito - la trasformano in preghiera.
_____
[1] Penso spesso a un incontro di anni fa con un autorevole cardinale della Curia romana. Alle mie lamentele sull'atteggiamento dei vescovi italiani nei confronti del canto gregoriano e della musica sacra, il porporato mi disse testualmente: "Il fatto che i vescovi italiani non apprezzino il gregoriano e la musica sacra è la conseguenza di una situazione ben più grave e delicata. La maggior parte dei vescovi non ha nessun interesse per la liturgia!". Peccato che queste parole il cardinale non le abbia tuonate davanti all'assemblea generale della Conferenza episcopale.
[2] Se non erro, studi di sociologia della vita religiosa hanno messo in evidenza il suo irrimediabile sfaldamento e declino nell'arco di una o al massimo due generazioni, circa 30 anni dall'inizio delle singole esperienze originali.
[3] In alcuni Paesi c'è purtroppo un forte ripiegamento sul presente che si traduce in una resistenza sorda e impedisce un'apertura serena a nuove ricerche e itinerari metodologici. Ci sono voluti alcuni decenni prima che non scandalizzasse più un approccio al gregoriano in una prospettiva di vergleichende Choralwissenschaft, lo studio cioè del canto romano-franco nel confronto con gli altri repertori, in primo luogo il romano-antico e l'ambrosiano. Stentano anoca ad affermarsi nuove prospettive suggerite dalla etnomusicologia, come la ricerca delle tecniche di composizione del tipo maqam. Per non parlare del suggerimento, proposto questo dalla geologia, di indagare sullemetamorfosi per contatto...
[°] per approfondire il Baroffio-pensiero: http://win.organieorganisti.it/baroffio_liturgiaincanto.htm ; http://win.organieorganisti.it/pseudochirografo_baroffio.htm ; https://www.organieorganisti.it/benedetto-xvi-ai-musicisti-di-chiesa
[#] (intervento alla tavola rotonda conclusiva della "XXXV Semana de estudios gregorianos" presso Abadia Santa Cruz del Valle de los Caidos, 29 agosto 2014)
giovedì 21 agosto 2014
Nel centenario della morte di S. Pio X papa...
Nonostante ciò, fortunatamente, ormai dal 1994, almeno l'Ufficio Liturgico Nazionale della CEI si occupa della formazione liturgico-musicale di coloro che, a vario titolo, si occupano della musica cultuale, all'opposto purtroppo non esiste alcun corso (o esame, come nella diocesi di Parigi) che sia effettivamente "abilitante" per l'esercizio della professione di organista di chiesa...
In proposito, sarebbe sufficiente che nei conservatori venissero potenziati i corsi di "organo per la liturgia" nel 2001 auspicati dalla CEI stessa e, in parallelo, i conservatori stessi prendessero accordi con le rispettive diocesi affinché vengano individuati posti di lavoro a concorso, grazie all'Otto-per-Mille alla Chiesa Cattolica, affinché i neo-diplomati possano effettivamente mettere pienamente a frutto le competenze raggiunte mediante l'alta formazione musicale ricevuta.
Riassumendo:
- necessità di più chiare direttive liturgico-musicali da parte dei vescovi
- accordi conservatori/diocesi in materia di reali sbocchi lavorativi a livello locale
- individuazione di fondi CEI da destinare a chiese importanti o a qualunque parrocchia richieda la presenza di un organista professionista
Utopie?! A me pare di no, basta che chi ha il potere di decidere, decida!
Noi organisti siamo a disposizione per un franco dialogo...
Paolo Bottini
[*] A conferma di questa apparentemente forte affermazione, desidero riportare la testimonianza di Giacomo Baroffio resa in occasione “XXXV Semana de estudios gregorianos” presso Abadia Santa Cruz del Valle de los Caidos il 29 agosto 2014):
Penso spesso a un incontro di anni fa con un autorevole cardinale della Curia romana. Alle mie lamentele sull’atteggiamento dei vescovi italiani nei confronti del canto gregoriano e della musica sacra, il porporato mi disse testualmente: “Il fatto che i vescovi italiani non apprezzino il gregoriano e la musica sacra è la conseguenza di una situazione ben più grave e delicata. La maggior parte dei vescovi non ha nessun interesse per la liturgia!”. Peccato che queste parole il cardinale non le abbia tuonate davanti all’assemblea generale della Conferenza episcopale.
lunedì 18 agosto 2014
Federico CAUDANA musicista ex allievo salesiano
Il 16 agosto 2014 è iniziato l’anno bicentenario della nascita di S. Giovanni Bosco. In proposito desidero ricordare un musicista “salesiano” che fu tra i primi allievi dell’Oratorio di Valdocco: Federico Caudana, il quale divenne nel 1907 organista e maestro di cappella del Duomo di Cremona e a partire dal 1924 tra i principali collaboratori (nonché, presto, intimo amico) dell’editore bergamasco di musica Vittorio Carrara. Il testo sotto riportato è tolto dalla biografia di Federico Caudana, dal sottoscritto compilata per i tipi del «Bollettino Storico Cremonese» uscito nel settembre 2009. Grazie per la cortese attenzione. Paolo Bottini
Federico
CAUDANA, che «con Lorenzo Perosi e Franco Vittadini fu nel campo
della musica sacra uno degli autori più eseguiti per l'ispirazione e
la correttezza dello stile»,1
nacque a Castiglione Torinese il 4 dicembre 1878 e morì a San Mauro
Torinese nella villa “Richelmy”, ove si trovava in villeggiatura,
il 29 luglio 1963; fu sepolto a Cremona il 31 luglio dopo funerali
solenni in cattedrale.
Rimasto
solo al mondo a soli quattro anni, per la morte di entrambi i
genitori, fu cresciuto dagli zii, in particolare da don Vincenzo
Caudana (fratello del padre e parroco a Pino Torinese) il quale lo
affidò successivamente all'Oratorio di San Francesco di Sales
(Torino-Valdocco) istituito da don Giovanni Bosco, ove entrò
all’inizio dell’anno anno scolastico 1892/93.
La
formazione che ricevette dall'ambiente salesiano condizionò
profondamente la sua vita: a testimonianza della sua “fede”
salesiana, tra le diverse opere di Caudana dedicate al grande santo
esiste una messa popolare ad una voce con organo composta
nell'ottobre 1956 e che l'autore volle dedicare a don Renato
Ziggiotti, all'epoca “rettor maggiore” della Società Salesiana.
Lo stesso Caudana bambino, inoltre, ebbe occasione di incontrare don
Bosco in persona:
Io voglio bene a don Bosco ed ai Salesiani. Ho avuto il bene di conoscere don Bosco nell'anno 1887 in settembre che di passaggio da Chieri a Torino ha dormito, con un altro sacerdote che ho pure conosciuto (don Branda), a casa mia: dopo quattro mesi è morto. È per me una soddisfazione aver conosciuto un santo così grande.2
Bisogna
sottolineare che don Bosco – buon dilettante d'organo, di violino e
pure compositore di musica (come testimoniato nella Vita di S.
Giovanni Bosco di don Giovanni Battista Lemoyne)
– aveva a cuore che i ragazzi ricevessero pure una seria educazione
musicale, per questo fondò a Torino la scuola di musica
dell'Oratorio di San Francesco di Sales il cui scopo era in primis
«promuovere la gloria di Dio contribuendo al maggior lustro delle
funzioni religiose sì nell'Oratorio che fuori», e in secundis,
«procurare un utile sollievo e un futuro mezzo di speciale risorsa
ai giovani artigiani più distinti per buona condotta e diligenza».3
Ed
è proprio all'epoca degli studi ginnasiali presso l'Oratorio
Salesiano di Valdocco che emerse il talento
musicale del giovane Federico, quando il maestro Giuseppe Dogliani,
laico cooperatore nell'Oratorio, lo ebbe nella sua corale e,
probabilmente, gli impartì i primi insegnamenti di pianoforte
avviandolo così allo studio della musica, la quale durante quei
cinque anni di permanenza,4
secondo i precisi intendimenti di don Bosco, costituì anche per
Caudana una costante presenza sia nella liturgia che nella
ricreazione. A Valdocco egli si trattenne sino al termine dell'anno
scolastico 1895/96 (perciò in un periodo posteriore alla presenza di
don Bosco, che morì il 31 gennaio 1888).
Le
cronache ci consegnano l'esecuzione di musica di Federico Caudana a
Valdocco ancora nel 1912 (dall'estate 1907 si trovava già a
Cremona): un «grandioso
Sacerdos
et Pontifex
del maestro F. Caudana, alternati colle soavi parti variabili in
gregoriano, ebbero davvero un'esecuzione meravigliosa» il
23 e 24 maggio 1912 da parte della schola
cantorum
dell'Oratorio Salesiano diretta da Giuseppe Dogliani.5
Nel
1934 Caudana diventa il compositore salesiano laico per eccellenza
grazie alla pubblicazione della cantata Don
Bosco Santo,
originariamente dedicata «al mio illustre ed amato maestro Dogliani
Cav. Giuseppe degno figlio di don Bosco»,6
la cui partitura venne pubblicata dall'editore Carrara nel numero di
settembre del medesimo anno del periodico «Melopea Educativa».
E
poi la canonizzazione di don Bosco, proclamato santo il 1 aprile
1934, spinge subito Carrara a progettare la pubblicazione di canti
utili per la messa propria in onore san Giovanni Bosco e a Caudana
«ex Allievo Salesiano» viene affidato il compito di mettere in
musica il testo «Contra spem, in spem credidit...»: ne esce un
mottetto di comunione a due voci pari con accompagnamento d'organo e
d'armonio che vien pronto il 20 aprile.
L'editore
di musica bergamasco Vittorio Carrara s'imponeva di mantenere, come
linea editoriale, una media facilità delle composizioni, in vista
della diffusione capillare in tutta Italia presso le tantissime
piccole scholæ
cantorum
e gli organisti dilettanti dalle limitate capacità, richiedendo
dunque ai propri collaboratori composizioni di facile approccio.
Ma
già nel 1894, a soli sedici anni, Caudana si mette in luce nel mondo
salesiano componendo Cinque cantate per Israele,
ma la vocazione di compositore è ben più precoce: a La
Spezia il 10 luglio 1889, non ancora undicenne, compone la romanza
per canto e pianoforte Ritornerà?;
a quest'epoca possiamo anche, quasi certamente, far risalire il
Valzer lento per
pianoforte, la cui partitura rimastaci possiede una tarda annotazione
autografa che ne rivela la composizione «quando era un giovinotto
sbarbato». Forse scrivibile agli anni di studio a Valdocco è
anche una melodia per tenore o soprano con pianoforte dal titolo
Canto dell'anima su versi di
Alfredo Morotti.
A favore dell'ambiente salesiano, inoltre, non mancheranno per Caudana occasioni di scrivere anche inni: nel 1943 ebbe occasione di mettere in musica un testo, scritto da don Secondo Rastello del collegio salesiano “Rota” di Chiari (Brescia), in omaggio al paese di Precasaglio di Ponte di Legno sede della “Casa Alpina don Bosco”; composto nel 1949 per il «prof. don Emilio Bonomi – Istituto Salesiano don Bosco – via dell'Istria, Trieste» è il mottetto Spiritus Domini, e in villeggiatura a «Giaveno ore 10 del giorno 19 agosto 1959» terminava di comporre un nuovo Inno ex allievi salesiani dopo aver ricevuto solo mezzora prima «la poesia per mezzo di mio genero Paolo».